Per ammirare tutte le bellezze che le Valli Bergamasche e le Alpi Orobie possono offrire non basterebbe probabilmente una vita intera; tra quelle da visitare almeno una volta c’è la Val di Scalve dove si può camminare non solo nella natura ma anche nel ricordo di una delle più grandi tragedie che hanno colpito la nostra regione.
La Val di Scalve si trova al confine tra la provincia di Bergamo e quella di Sondrio, è attraversata dal torrente Dezzo ed è tributaria della più famosa Val Camonica. Da Milano si arriva in circa un paio d’ore passando da Bergamo e attraversando il Passo della Presolana. Gli amanti dei trekking non avranno che l’imbarazzo della scelta tra laghi, cascati, passi e rifugi. Oggi però vi parlo di quella che probabilmente è l’escursione simbolo di questa valle: il trekking per raggiungere la Diga del Gleno.
La Salita alla Diga del Gleno
Questa escursione unisce bellissimi scorci della Val di Scalve con il ricordo della tragedia che colpì la zona nel 1923. Inaugurata a fine ottobre, la diga serviva per alimentare due centrali elettriche poste più a valle lungo il letto del torrente. Il 1 Dicembre 1923, dopo settimane di segnalazioni di perdite dalla base, la diga crollò e milioni di metri cubi di acqua si riversarono nella valle travolgendo le frazioni di Bueggio e Azzone fino a Darfo per poi terminare la loro corsa distruttiva nel Lago d’Iseo.
A testimonianza del disastro è rimasta una parte della diga che orge alle pendici del monte Gleno, uno dei più importanti della catena delle Orobie. Per raggiungere la diga e il lago si può scegliere tra diversi punti di partenza; il sentiero che vi propongo oggi è quello che parte da Pianezza, un piccolo borgo della valle a 3 km da Vilminore.
Nel 2021 tutti i weekend di giugno, luglio e settembre e tutti i giorni dal 24 luglio al 31 agosto una navetta collegava Vilminore con Pianezza (non ho trovato info per quest’anno ma la frequenza sarà probabilmente la stessa). In tutti gli altri giorni potete arrivare fino a Pianezza dove c’è un piccolo parcheggio; se non siete fortunati sembra che sia possibile parcheggiare lungo la strada che sale al borgo.
Da Pianezza parte un sentiero di circa 2,5 km percorribile in poco più di un’ora. Attraversate le baite e un prato sulla destra si trova una strada che porta fino all’inizio del sentiero vero e proprio. Il primo chilometro e mezzo è la parte più faticosa perché tutta in salita e a tornanti ma sarà qui che supererete l’intero dislivello di circa 270 metri; questa mulattiera corre lungo i tubi della condotta forzata e raggiunge quota 1500 metri.
A questo punto il resto del percorso è completamente in piano e avrete poi tempo di riposarvi nelle distese fiorite che circondano il Laghetto del Gleno. La prima parte del tratto pianeggiante si trova all’interno del bosco prima di arrivare a un tratto scavato nella roccia che offre una vista spettacolare su tutta la valle. La Diga compare tutto a un tratto con la sua imponenza appena dopo una svolta; arrivati alla sua base fa ancora più impressione e rende l’idea dell’immane tragedia che colpì la zona.
La Cascata del Vò
In 15 minuti di auto si può raggiungere da Pianezza la partenza del sentiero che porta alla Cascata del Vò. La piccola valle, che prende il nome dal torrente Vò si apre poco prima del paese di Schilpario ed è una meta perfetta per le giornate estive, anche in compagnia di bambini.
Il parcheggio si trova in località la Paghera e si raggiunge svoltando a sinistra (provenendo da Pianezza) subito dopo il ponte della provinciale 294; qui ci sono diversi spiazzi dove lasciare la macchina. Il sentiero CAI 413/a parte poco più avanti, in prossimità dello Chalet del Vò, e si snoda all’interno di un bosco di abeti e pini fino alla Cascata, raggiungibile in circa 30 minuti.
Lungo il sentiero si possono osservare testimonianze di una storia centenaria: quella dei trafficanti e dei minatori. Questo sentiero è stato percorso per secoli dai trafficanti che da qui scollinavano verso la Valtellina. Lungo il sentiero si trovano una “poiat”, una struttura di rami e tronchetti di legna per la fabbricazione del carbone, e una “reglana”, il forno di fusione dei minerali a cui si accedeva proprio tramite la mulattiera. Entrambi importanti della vocazione mineraria di questa valle, vocazione già nota ai tempi dei romani.
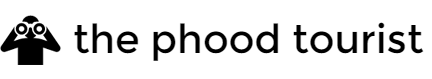
 Thephoodtourist
Thephoodtourist
 Thephoodtourist
Thephoodtourist  Thephoodtourist
Thephoodtourist  Thephoodtourist
Thephoodtourist  Thephoodtourist
Thephoodtourist  Thephoodtourist
Thephoodtourist  Thephoodtourist
Thephoodtourist